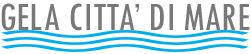Dalla fondazione di Terranova alla Gela di oggi
Dalla fondazione di Terranova alla Gela di oggi
Ai primi del ‘700 l’ignoto autore di una Relazione della città di Terranova indirizzata al duca della città, Nicolò Pignatelli, scriveva che Gela “perché è stata rifatta tre volte si chiama adesso Terranova”, facendo derivare per l’occasione Ter (ra) nova dal latino Ter nova (tre volte nuova), a conferma di un fatto storico di cui aveva conoscenza. Nella sua storia plurimillenaria, in effetti, Gela è morta e risorta, come del resto, tante altre città del mondo, ma poche possono vantare fondatori e rifondatori così illustri come quello che vanta Gela, dal mitico Antifemo al più reale Timoleonte, al più vicino Federico II di Svevia.
Solo qualche decennio separò la distruzione del 405 a.C. ad opera dei Cartaginesi dalla ricostruzione timolontea del 339– 338 a.C., ma ben quindici secoli di totale (o quasi) abbandono passarono tra la distruzione della città greca del 282 a. C. dovuta all’agrigentino Finzia e la rifondazione federiciana, come la ricerca storica ed archeologica ha inoppugnabilmente dimostrato; mentre negli ultimi decenni del ‘300 ci fu una terza, e fino a poco tempo fa quasi sconosciuta, distruzione della città, della cui rinascita non poté vantarsi alcun eroe eponimo, perché fu il frutto di una lenta e travagliata ripresa.
Nel secondo lungo intervallo, durante i secoli della dominazione romana e bizantina, dell’antica città greca, deportati gli abitanti a Finziade (Licata) o fuggiti verso l’interno (a Philosophiana Gelensiom), era sopravvissuto solo il nome, anche se deformato, nel refugium esistente alla foce del fiume e in un latifondo appartenente alla Chiesa di Roma. Poi s’era perso anche quello, per cui gli scarsi visitatori che erano passati da quelle parti e i più numerosi pirati che avevano veleggiato in quel mare, dalle colonne degli antichi templi svettanti tra le rovine, avevano denominato la collina, Colonnario , e il fiume che vi scorreva accanto, Fiume delle Colonne (in arabo uadi as – Sawari).
Con questo nome la collina venne chiamata certamente al tempo dei Normanni, come ci informa il geografo della corte di Ruggero II, al-Idrisi; e dagli intellettuali che vissero alla corte dei Normanni e poi degli Svevi questo fatto venne collegato al mitico classico Ercole “piantatore di colonne”; il che bastò per individuare in Ercole l’eroe eponimo primo fondatore della città, che fu creduta Eraclea. La “città di Ercole” effettivamente esistita al tempo dei Greci, ma un centinaio di chilometri verso occidente, alla foce del Platani. Ce ne dà testimonianza uno scrittore della corte sveva, Guido delle colonne, il quale scrive nella sua Storia di Troia: “Onde si disse che Ercole per ricordanza della sua memoria ficcò le colonne in una parte della Cicilia, cioè dalla parte di Barberia; il quale luogo ancora si chiama Colonnario, e quella terra ch’era ivi per addietro si chiamava Erculea, ma corrotto il nome, alquanti la chiamavano Eraclia(…). Ed in quella terra Federico II, prencipe della Repubblica dei Romani e Re di Cicilia, fece edificare una Terra, considerando che il luogo era utile agli abitatori per il suo sito(…) e chiamasi Terranova”.
L’imperatore Federico II aveva maturato l’idea di fondare la città tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta del XIII secolo, quando si era reso conto che non avrebbe potuto restituire all’agricoltura la fertile pianura del Gela, da secoli abbandonata, senza ridar vita all’antica città, perciò, dopo aver assicurato il mare dalla pirateria saracena stipulando un trattato commerciale con l’emiro di Tunisi, nel 1233 poté controllare personalmente la realizzazione del suo piano, come ci suggerisce una lettera del dicembre 1233 indirizzata da Butera a papa Gregorio IX.

La torre di avvistamento in Via Matteotti, da notare gli archi che formavano la Porta del Salvatore o Porta Licata – 1970 circa
Un documento del 1249 ci informa che a soprintendere ai lavori della nuova Eraclea nei primi sei anni fu Matteo Marchiafava, secreto (una specie di ministro delle finanze) di Sicilia dal 1233 al 1239, il quale trasferì coattivamente nella nuova città non solo coloni provenienti da varie parti dell’Isola e del continente, cui venivano assegnati lotti di terreno ( tenimenta terrarum ) con l’obbligo di coltivare la terra in cambio del terraggio (tributo in natura), ma anche altri cui venivano assegnati lotti con l’obbligo di costruire a loro spese case ed altri edifici essenziali alla vita della città. Uno di costoro, il calabrese Pietro Ruffo, divenuto nel frattempo priore del convento di Terrana, nel Caltaginorese, essendogli venuti a mancare i soldi per completare il lavoro, fu costretto a vendere al vescovo di Patti uno dei lotti con gli edifici già costruiti; e a firmare l’atto troviamo sei notai, un prete, tre maestri artigiani e sette non qualificati, tra i quali sei sono calabresi ed uno di Caltagirone, con la composizione quasi completa (manca il nome del baiulo) della Curia baiulare (una specie di Giunta comunale) del tempo.
Propabilmente, uno dei lotti che Piero Ruffo si riservò è proprio quello dove in quegli stessi anni veniva innalzata, sulle rovine di un santuario d’età greca, la chiesa di santa Maria di Betlemme (in dialetto locale, Bitalemi), che nel 1249 viene ricordato come suffraganea all’abbazia di Terrana, allora appartenente all’Ordine Ospedaliero Gerosolimitano, e che oggi è stata sostituita da una cappelletta meta di pellegrinaggio femminile nel mese di maggio. Nello stesso periodo, presumibilmente, veniva costruita, su un leggero rilievo a nord della collina, la chiesa di Santa Maria dell’Alemanna, che nel 1243 veniva affidata all’altro ordine cavalleresco favorito da Federico II, quello Teutonico (o degli alemanni), e che, come la prima, è stata sostituita recentemente – abbattuto negli anni settanta quel che restava dell’antica chiesetta – da un’anonima costruzione moderna. Essa ha lasciato in eredità alla chiesa Madre l’immagine bizzantinegiante dipinta su tavola della Madonna dell’Alemanna, che la leggenda vuole rimasta seppellita sotto le rovine dell’antica chiesa durante un’incursione dei Saraceni, ritrovata miracolosamente intorno al 1476 e proclamata patrona della città nel XVII secolo. Riscontri archeologici, infine, fanno risalire verso la fine dello stesso secolo (anche se le notizie letterarie che ne abbiamo sono più tarde) la chiesa di San Biagio, commenda dei Templari, e quella di san Giacomo, probabilmente appartenente anch’essa ad un ordine Ospedaliero.
E’ chiaro che con la nuova fondazione l’imperatore si proponeva il duplice obiettivo di ripopolare e sfruttare economicamente un fertile territorio del suo regno e di diffondervi la religione cristiana e tale obiettivo non si poteva perseguire senza garantire la sicurezza dei costruttori e dei coloni mediante opere di fortificazioni. Un cronista contemporaneo, Salimbene de Adam, scrisse che “in ogni città del suo demanio l’imperatore volle avere un palazzo o un castello”, e non si vede perché Eraclea-Terranova dovesse fare eccezione, tenuto conto, perciò, che non mancava certo il materiale da costruzione tra i ruderi degli edifici anche monumentali della ricca città greca, si deve ritenere che a difesa immediata dei costruttori sia stato edificato subito anche il castello; mentre nei decenni successivi, oltre a far sorgere negli immediati dintorni chiese e centri d’accoglienza – che, guarda caso, venivano affidati ad ordini religiosi-cavallereschi, i quali avevano proprio il compito di difendere i cristiani dagli infedeli, – si sarà provveduto ad innalzare anche il muro di cinta.
In ogni caso, la città nasceva nella parte orientale della collina già occupata dalla Gela arcaica, tra i due restringimenti della collina costruiti dall’area del Calvario e dal vallone di Pasqualello, con un impianto regolare fondato sull’incrocio di due ortogonali in cui insisteva la Chiesa Madre, Santa Maria de Platea, con l’area del mercato (platea) nell’asse minore, come in quasi tutte le nuove fondazioni del tempo in Italia e in Europa, e con il castello nella parte sud- orientale a controllare la foce del fiume.
Nel giro di pochi anni, la nuova città accolse popolazione proveniente da tutte le parti ed ebbe subito un ordinamento cittadino, universitas), con il suo baiulo, i suoi tre giudici e i sei notai; la produzione agricola si sviluppò tanto, che nel 1239 i coloni posero all’imperatore il problema di un approdo (il futuro Caricatore) da cui potere esportare “fino a sei salme” di cereali. Già sotto gli ultimi Svevi, Eraclea, che ormai tutti chiamavano Terranova, era diventata un’importante centro di esportazione del grano, frequentato da mercanti pisani, genovesi, catalani, e nel 1261 i Francescani Conventuali costruivano fuori le mura il loro convento.
Fu un vero e proprio boom economico e demografico, in seguito al quale, a quarant’anni dalla fondazione, il cronista Saba Malaspina la elencava tra le principali città della Sicilia; e ciò non poté non sollevare le gelosie delle comunità confinanti di Ragusa, Caltagirone, Grassuliato e Butera, che, con un documento angioino del 1274, vennero diffidate dal molestare gli Eraclesi; lo stesso si dovette fare il 4 settembre del 1276 con gli abitanti di Odogrillo (Dirillo), ai quali fu notificata la delimitazione del territorio di pertinenza della città.
A quel tempo, Terranova era arrivata a registrare 2.214 “fuochi”, equivalenti a circa 8.500 abitanti, il che la collocava al quinto posto tra le città siciliane, dopo Palermo, Messina, Trapani e Corleone, e molto prima di Catania e Siracusa. La ribellione anti-angioina dei Vespri (1282) e la successiva guerra (1282–1302) non arrestarono tale sviluppo, e per parecchi decenni ancora essa rimase tra le più popolose e ricche città dell’Isola per la sua produzione agricola-pastorale, come risulta dai registri aragonesi del fodro (tributo in natura) pagato a Pietro III d’Aragona.

La torre di avvistamento in Via Matteotti, da notare gli archi che formavano la Porta del Salvatore o Porta Licata – Febbraio 2009
Terranova ospitava anche un quartiere ebraico, la Giudecca, e, secondo i registri vaticani nel 1308 – 10, vi si trovavano ben ventidue chiese, tra urbane e rurali (contro, per esempio, le sedici di Piazza), tra cui ricorrono i nomi, oltreché della chiesa Madre, Santa Maria di Platea, di Sant’Antonio, di San Giovanni, di Santa Chiara, di San Pietro, di Santa Maria Annunziata, di San Nicola della Giudecca, di San Giacomo, di Sant’Ippolito, di Santa Maria di settefarine, di Santa Maria di Betlemme, a parte la chiesa di San Francesco e , probabilmente, quella di San Biagio, di cui abbiamo notizia più tardi, nel 1313, nella chiesa Madre, venne eletto il vescovo di Siracusa. Pietro di Montecatini.
Di tutti questi edifici, non rimangono resti significativi, tranne della chiesa di San Biagio – oggi addossata al muro del cimitero monumentale dominato dal campanile dell’ottocentesca chiesa di San Nicola da Tolentino – con il suo portaletto archiacuto incassato in un arco ribassato e sormontato da una finestra ad occhio, e con il sobrio interno absidato, oggi adibito a sala conferenze dell’adiacente Bibblioteca comunale; mentre della chiesa medioevale di San Giacomo, il Portaletto archiacuto, poggiante su colonnine incassate, negli anni ’50 è stato smontato per costruire sul sito dell’antica chiesetta la moderna San Giacomo Maggiore (opera dell’architetto Salvatore Cardella), e recentemente installato sulla piazza antistante in maniera discutibile.
Più consistenti sono i resti delle fortificazioni medievali, con tutti i rimaneggiamenti per riparazioni e ricostruzioni che hanno subito nel corso dei secoli finché vennero realizzate come tali. Il castello, che deve la sua prima origine all’età federiciano, ha certamente attraversato numerose modificazioni, conservando, tuttavia, la sua forma quadrilatera irregolare che ci viene tramandata da disegni del ‘500 e del ‘600. Una parte venne abbattuta nel ‘700, ma sono ancora individuabili ad est e a sud tre torri incastrate fra le costruzioni civili, e un recente scavo all’interno del cortile ha messo in luce i resti di un torrione, ascrivibile all’età della fondazione, fornito di due finestre archiacute con strombature ed una postierla. L’eliminazione delle abitazione addossate alla cortina muraria che accompagnava le torri superstiti, se possibile, migliorerebbe la visibilità dell’edificio, soprattutto sulla piazza Calvario.
Il muro di cinta, della cui esistenza certa fin dal XIV secolo, ma che, moto probabilmente, era stato innalzato già nel secolo precedente, chiudeva la città federiciana nella parte orientale della collina, dal castello fino al vallone Pasqualello, ed aveva inizialmente solo quattro porte: porta del Castello, detta anche porta Prenestrina (poi porta Vittoria), verso est, porta Caltagirone verso nord, porta del Salvatore (poi porta Licata) verso ovest, e porta Marina verso sud.
Situata al centro di un ampio golfo prive di difese, la città era esposta alle incursioni dei pirati barbareschi e, quando queste si intensificarono dopo il 1336, il muro di cinta non bastò più ad assicurarne la vita, provocando presto crisi e decadenza demografica, che nei registri fiscali del 1356 la fanno apparire tra le più povere città del regno; a ciò si aggiunga la peste bubbonica del 1347-48 e la guerra civile tra Latini e Catalani, alla quale Terranova partecipò, per istigazione del Capitano Luca di Canniarato, dalla parte dei latini. Finché nell’aprile del 1360, assediata dal catalano don Artale Alagona, essa si ribellò al Capitano, lo buttò giù da una torre di legno adiacente la porta Caltagirone e tornò ad obbedire al re Federico IV.
La città aveva perso ormai la sua importanza, e Federico IV nel 1366 la cedette in feudo a Manfredi Chiaramonte, per ricompensarlo di essere passato dalla sua parte, dopo averne ridotto il territorio con la cessione a Pietro di Cannariato del feudo di Mautana e ad Antonio de Perlaxo di quello del Castelluccio. Quest’ultimo edificio allora certamente esisteva già, senza che ciò basti ad attribuirne la costruzione a Federico II; ma quel che più importa è che esso domina ancora con la sua mole rettangolare, da una collinetta rocciosa a sette chilometri dalla città, la piana e il corso del fiume Gela, a poca distanza dalla “presa” di Grotticelle. Dieci anni dopo, i collettori pontifici vi poterono registrare solo 350 nuclei familiari solvibili, cioè 1.500–2.000 abitanti circa (contro i 3.300 di Caltanissetta, gli 8.000 di Piazza, i 9.000 di Siracusa).
In un anno imprecisato tra il 1370 e il 1390, sembra doversi collocare la terza distruzione di Gela da parte dei pirati barbareschi; ce ne da notizia solo un documento diplomatico del 1399 di re Martino il Giovane, che ricorda “ com lo Rey de Tunis fa guerra contro Sicilia et tot anys continuament ab VI gelees damnifica lo dit Regne prenent gent… et com prengueren Terranova… ”; e quasi mezzo secolo dopo (1516), la baronessa Maria Concessa d’Aragona ricordava ai vassalli terranovesi che i suoi predecessori avevano ricostruito e ripopolata la città “ a mauris, sacre et ortoxe fidei inimicis, destrutta et dispoliata ”.
Non sappiamo quando sia ricominciato il ripopolamento, ma certo la città aveva ripreso a vivere nel 1391, allorché vi venne inviato come parroco di Santa Maria di Platea un prete di Mazzarino e la chiesa di San Biagio venne conferita agli ordini degli Ospedalieri, mentre la “città e il Castello” venivano concessi in feudo al catalano Peire de Planell.
Nel 1393, una nuova scorreria tunisina, che vi sorprese in visita pastorale il vescovo di Siracusa, Tommaso de Herbes, fatto prigioniero, dimostrò che la città era ormai indifendibile dalle incursioni, sia per debolezza del sistema difensivo, che per il ridotto numero degli abitanti; così quando nel 1396, re Martino autorizzò l’ universitas ad impiegare i proventi della gabella degli erbaggi nella “fabbricazione e riparazione” delle mura, la prima cosa che si pensò di fare fu ridurre la cinta muraria a poco meno della metà della superfice d’epoca federiciana, lasciando fuori tutta la parte occidentale, che assunse il nome di Terravecchia , mediante la costruzione, all’altezza dell’attuale via Navarra Bresmes, di un muro su cui si apriva la porta dei Carri, come documentano stampe, disegni e documenti d’archivio dal XVI secolo in poi.
Un disegno del 1584 di Camillo Camilliani ci mostra, in questa parte della muraglia, l’esistenza di otto torri, escluse quelle del castello, di cui una, semicircolare, sulla via Mediterraneo, è conservata quasi intatta, e un’altra appare incastrata tra le costruzioni civili, nelle vicinanze, è stata scoperta recentemente, la vecchia porta Marina, medievale, ad arco acuto, sovrastata da mensoloni antropomorfi, rinchiusa dentro il bastione della porta Marina, costruito nei primi del ‘600 insieme al bastione del Carmine, quando si decise di rinforzare la cinta dalla parte del mare; altri tratti della muraglia sono visibili nella parte settentrionale che da sulla via Generale Cascino.
Ridotta ad un piccolo borgo malamente fortificato, Terranova vivacchiò a lungo passando da un signore feudale all’altro, nonostante Martino I, nel 1398 e nel 1401, avesse promesso di restituirla al demanio; finché nel 1453 finì nella mani di Giovanni d’Aragona, signore di Avola. In questo periodo, dentro la nuova cerchia muraria furono costruiti, accanto al castello, il convento di Sant’Agostino (1456) con la chiesa di San Giuseppe, e un po’ verso il centro quello dei Benedettini, nel 1499, i Francescani Conventuali, costretti ad abbandonare il loro convento fuori le mura, ottennero nei pressi della Chiesa Madre la chiesetta abbandonata di San Michele, che dedicarono a San Francesco d’Assisi.
Nonostante le moratorie e i privilegi concessi a chi si stabiliva nella città, e nonostante i viceré obbligassero le città dell’entroterra, tra cui Piazza e Caltagirone, a correre in aiuto del Capitano d’armi di Terranova in caso di minaccia di scorrerie saracene, la città rimase quasi spopolata per gran parte del ‘400, passando a stento, a giudicare dal suo gettito fiscale (da 4 a 5 onze), dai 400 – 500 abitanti degli inizi del secolo ai 700 – 800 del 1478.
Negli ultimi decenni del XV secoli, gli Aragona si impegnarono nel ripopolamento e nella valorizzazione del loro feudo, e nella “numerazione” del 1505 furono censiti 374 “fuochi”, che portano ad ipotizzare un totale di 1.500–1800 abitanti. Su di essi, don Carlo d’Aragona nel 1507 la comprò da Ferdinando II il mero e misto imperio, cioè il diritto di amministrare giustizia, i Terranovesi, che avevano già lamentato la durezza della soggezione feudale, chiesero di poter riscattare tale diritto, e alla morte di don Carlo rifiutarono il giuramento alla figlia Maria Concessa, resistendo con le armi, ma furono costretti a cedere nel 1516.
Terranova rimase signoria feudale per altri tre secoli, passando nel 1520 ai Tagliavia di Castelvetrano e nel 1650 ai Pignatelli di Monteleone, e finendo tra gli innumerevoli domini siciliani, spagnoli e americani di una delle più potenti di Spagna, Pignatelli-Aragona-Cortes, con il titolo di marchesato dal 1530 e di ducato dal 1561. Costoro, a parte Carlo d’Aragona da giovane (1497), non risiedettero mai nella città, né risulta l’abbiano quasi mai visitata, limitandosi a governarla e a percepire i proventi tramite i loro secreti . Su un territorio allora valutato 6.500 salme, i baroni ne possedevano 3.000, di cui solo la metà coltivate; 2.500 erano costituite dai boschi comuni (Feudo Nobile, Passo di Piazza, Priolo Spinasanta, Marina e Manfria); le rimanenti 1.000 salme erano occupate dalle “tenute” dei privati.
L’economia della città era fondata esclusivamente sulla cerealicoltura e sull”allevamento ovino, e per incrementarli i duchi d’Aragona dal 1563 fecero costruire sul fiume Gela la prima opera di ingegneria idraulica dell’età moderna di cui abbia notizia in Sicilia, la “presa” (diga) di Grotticelle, inizialmente in terra battuta, rinforzata con i pali di legno e sostituita nel 1638 da una muratura ad opera dei maestri di Aidone, Leonardo e Francesco di Luca.
La popolazione, intanto, andava passando dai 1.500 abitanti del 1505 ai 5.000 dalla fine del secolo, per cui, saturata l’area della piccola cinta muraria, aveva ripreso ad estendersi nella Terravecchia con un rabattello (sobborgo) fuori la porta dei Carri; già a metà del secolo, la città appariva – come scrisse lo storico Tommaso Fazzello – “doppia, cioè la vecchia e la nuova, et ambedue son cinte di mura, ma quella ch’è vecchia è verso ponente e quasi rovinata e diserta”. All’estremità occidentale della Terravecchia, nel 1514 si cominciò a costruire il convento del Carmine, e nel 1574 i Capuccini iniziarono a edificare fuori le mura il loro convento sulle rovine di quello abbandonato dai Conventuali.
Contro le frequenti scorrerie dei pirati turco-barbareschi, i viceré spagnoli avevano pensato di impiantare sulle coste siciliane un sistema di torri di avvistamento che segnalassero alle città costiere l’avvicinarsi delle navi corsare; il golfo di Terranova fu ben difeso ad occidente del castello di Licata e dalle torri di Falconara e Manfria, mentre la parte orientale fino a Camarina rimaneva sguarnita e coperta da una boscaglia, “ricettacolo di fiere e di gente di malaffare”, come osservò il Camilliani. Nel 1582 i pirati arrivarono a catturare e trascinare in schiavitù ottanta Terranovesi che non erano riusciti a rifugiarsi entro la cerchia ristretta delle mura; si decise allora, l’anno dopo, di ripristinare la cinta muraria federiciana, comprendendovi anche la Terravecchia; e sono di quest’epoca certamente gli altri tratti murari ancora visibili, quelli di via Verga e di Via Matteotti. Negli anni successivi, si costruirono la torre dei Cappuccini, a difesa del convento, e la torre dell’Insinga per vigilare sul Caricatore, tutte e due abbattute nell’800; mentre la torre di Manfria (anch’essa dalla fine del XVI secolo) si erge ancora ad una decina di chilometri ad oriente della città, con la sua mole quadrata, a dominare il caotico villaggio turistico sulla spiaggia sottostante.
All’interno della cinta muraria, nei primi del ‘600, su progetto dell’ingegnere Raffaele Locadello, veniva costruito un quartiere addossato alla muraglia, tra la porta del Salvatore e il convento del Carnime, per l’alloggio delle milizie cittadine delle comarche di Piazza e di Caltagirone, le quali appena ricevuto il messaggio delle torri costiere, trasmesso da altre torri poste su luoghi eminenti, erano tenute a portare soccorso ai cittadini di Terranova.
Ciononostante, nel corso del secolo, le pestilenze (in quella del 1577 i monaci di San Francesco d’Assisi dovettero bruciare i loro archivi) e le carestie provocarono una nuova crisi economica e demografica che fece diminuire la popolazione dalle 5.059 anime del 1616 alle 4.151 del 1651, per ritornare a 5.289 abitanti solo nel 1681; sicché all’interno della cinta muraria c’erano ancora spazi vuoti e rovine di vecchi edifici, come quelle di convento di Santa Chiara, dove nel 1607 gli Osservanti costruirono il convento e la chiesa di Santa Maria di Gesù, i cui resti, a loro volta, nel 1936 furono sostituiti con un edificio scolastico.
( Ndr L’edificio scolastico è stato progettato e seguito nella sua costruzione dall’ingegnere gelese Gaetano Di Bartolo).
Tra il 1640 e il 1655, i Frati Conventuali dovettero ricostruire la chiesa di San Francesco d’Assisi che andava in rovina e l’arricchirono di pregevoli stucchi, di un soffitto ligneo a cassettoni dipinto, di un’acquasantiera di marmo cinquecentesca, cui, nel ‘700, si aggiunsero tele di buona fattura (non ancora bene studiate), oltre ai monumenti funebri gentilizi, tra i quali quello del 1748 dedicato a don Carlo Chiarandà.
Nello stesso periodo, mentre i documenti riportano l’apertura di nuove porte sulle mura, una porticella della chiama e una porta di San Giovanni verso l’interno e una porta (purtusu) della Graticola, deve essere stato realizzato il portale baroccheggiante della chiesa dell’Annunziata dell’annesso convento del Carmine, che nel corso del secolo fu luogo di pellegrinaggio per il particolare culto popolare riservato al Crocefisso ivi custodito, e che conserva ancora una tavola rappresentante la Crocifissione con la Vergine e San Giovanni, opera del 1616 di ignoto pittore siciliano, che tuttavia – come sostiene Giulia Davì – mostra notevoli tangenze con l’arte di Filippo Paladini” e “un linguaggio affine” a quello del messinese Antonio Catalano il Vecchio (1560 – 1630).
Nel frattempo, le spese per la manutenzione delle mura, le angherie dei secreti e la pressione fiscale indebitavano sempre di più la comunità, ma si indeboliva anche il potere ducale, e un gruppo di famiglie emergenti, i Triolo, i Li Gregni, i Labiso, i Fischietti, i Giurato, gli Aldisio, i Mallia, divise in “ceto dei nobili” (cui spettavano le cariche di Capitano, Sindaco e Giurato) e in “ceto dei professori” (che detenevano le cariche giudiziarie), aspiravano a liberarsi dalle pastoie del sistema feudale: ci riuscirono solo nel 1789, pagando un riscatto per tornare al demanio.
Nel corso del ‘700, la città si estese verso occidente attorno alla chiesa di San Giacomo, con il Borgo, raggiungendo nel 1747 la densità dell’età svevo-angioina (8.557 abitanti). Si sviluppavano la viticoltura e la cotonicoltura, e dalla salicornia si otteneva dell’ottima soda per l’esportazione. Il duca contribuiva allo sviluppo economico, completando la sistemazione idraulica della piana ad opera dell’architetto locale Andrea Gigante e del milanese Felice Visconti, sostituendo tra il 1770 e il 1785 la vecchia presa” di Grotticelle con una nuova diga in muratura, e convogliando delle acque del torrente Maroglio in quelle del Gela. Un viaggiatore che la visitò alla fine del secolo, Torre di Rezzonico, ritenne l’opera “piuttosto regia che privata”.
La ripresa economica è testimoniata da una notevole attività edilizia. Nel 1738, una chiesa esistente dal 1626 fuori porta Calvario, quella intitolata a San Francesco di Paola, veniva trasferita entro le mura, nell’attuale piazza Salandra; ma oggi, chiusa al culto, se ne può ammirare solo la sobria facciata adorna di un portale barocco.
Tra il 1766 e il 1794, si cominciava a edificare, utilizzando anche materiale degli antichi templi greci, al posto della vecchia chiesa di Santa Maria di Platea, una nuova grande Chiesa Madre; essa fu completata con la costruzione, nel 1837, di una nuova torre campanaria in sostituzione di quella medievale ad opera dell’architetto gelese Emanuele Di Bartolo, e nel 1844, su disegno dell’altro architetto gelese Giuseppe Di Bartolo, di un’elegante facciata neoclassica fortemente elevata al centro in corrispondenza della navata centrale, adorna di colonne aggettanti per tre quarti, di ordine dorico al piano inferiore e ionico in quello superiore, culminante in un frontone con acroteri; si notano due complessi statuari rappresentanti la Fede e la Carità .
Sotto i Borboni, la città, che già superava i 9.000 abitanti, diventò capoluogo di un distretto comprendente Butera, Riesi, Mazzarino e Niscemi, dal punto di vista ecclesiastico, nel 1818 veniva assegnata alla diocesi di Caltagirone e nel 1844 a quella di Piazza Armerina. Per gran parte del secolo, la classe dirigente locale fu impegnata nella “questione demaniale”, una lunga vertenza giudiziaria per riavere le terre e gli usi civici usurpati dagli Aragona-Pignatelli, che verso la fine si trasformarono in “questione sociale” sotto la spinta del bracciantato agricolo.
Nei primi decenni dell’800, l’economia ristagnava e la popolazione calava: solo due terzi del territorio comunale risultavano ancora coltivati. E ben presto il controllo della vita economica e politica passò alla piccola nobiltà locale e alla borghesia agraria e intellettuale, che partecipò ai moti risorgimentali e ridiede slancio all’economia e alla cultura con l’istituzione di scuole, di un teatro e del Collegio Pignatelli: alla vigilia dell’Unità d’Italia, la popolazione raggiungeva i 13.000 abitanti e il vecchio Caricatore aveva cominciato ad esportare, oltre ai prodotti agricoli, zolfo invece di soda.
Assegnata alla Provincia (Intendenza) di Caltanissetta con il ruolo di Sottointendenza, tra il 1861 e il1911 la città conquistava ad una agricoltura prevalentemente latifondistica le residue due terre incolte, in un contesto di lotte sociali e politiche che videro come protagonista il socialista Mario Aldisio Sammito (1835–1902), fondatore del locale Fascio dei lavoratori. La popolazione passava da 13.754 a 24.000 abitanti. Nel cinquantennio successivo, superata l’emergenza di due guerre mondiali, recuperato l’antico nome di Gela (11 novembre 1927), venne debellato il latifondo in due ondate di lotte sociali e politiche che impegnarono il primo e il secondo dopoguerra (1919-20 e 1944-48), e da cui emerse come protagonista Salvatore Aldisio (1890–1964); mentre lo sviluppo dell’irrigazione, soprattutto dopo la costruzione della diga Disueri, incrementava la cotonicoltura.
Il miglioramento delle condizioni igieniche ed economiche portava gli abitanti di Gela dai 26.000 del 1921 agli oltre 54.000 del 1961. Nell’immediato dopoguerra, si ebbe la scoperta delle mura greche di Caposoprano , che provocò la nascita del museo archeologico, e nei gelesi la speranza di un futuro turistico. Ma più dirompente fu la scoperta del petrolio (1956), che in breve condusse alla costruzione dello Stabilimento petrolchimico (1961) e all’avvio dell’industrializzazione, la cui prima conseguenza fu lo sviluppo caotico dell’insediamento urbano, spesso a danno della memoria storica.
Fonte: Ignazio Nigrelli